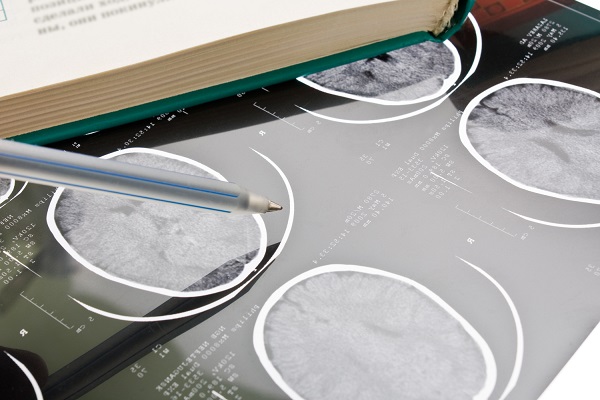L’islamofobia è un fenomeno diffusosi silenziosamente negli ultimi decenni, per poi emergere in ambito scolastico, familiare e sociale ad ogni attentato terroristico, omicidio e/o femminicidio ad opera di musulmani, nonché in ogni dibattito pubblico sull’immigrazione proveniente dai Paesi Arabi. Per rendersene conto, basta parlare della questione islamica con amici, parenti e conoscenti e probabilmente una buona maggioranza oggigiorno si esprimerà in toni poco pacifici, per usare un eufemismo. Tuttavia, fino a qualche anno fa sarebbero stati in pochi a dirsi esplicitamente antislamici: il fenomeno ha avuto un picco in un momento storico ben preciso e con effetti devastanti sulla percezione sociale degli islamici e della lotta al terrorismo, come vedremo. Così, un pregiudizio implicito è andato trasformandosi in un atteggiamento consapevole, osteggiato e giustificato dal bisogno di proteggere ciò che si è costruito in questo Paese. Sarebbe ottimistico pensare che le persone abbiano preso coscienza dei loro comportamenti inconsci, ma l’islamofobia reca questo nome proprio perché “fobia” non indica solo “paura”, come riferisce la sua etimologia, ma anche aggressività, che può essere intesa come ideologica e verbale, non solo fisica. In questo caso la paura è uno dei tanti fattori (o forse l’unico scatenante) che non solo generano ostilità, ma la alimentano ogni volta che essa si manifesta, creando un effetto a catena in cui l’agente non è più attivo ma passivo di azioni su cui non ha più il controllo.
Effettuare una semplice ricerca utilizzando le più svariate parole chiave legate all’antislamismo può certamente aprire gli occhi all’utente medio sulla quantità di odio che circola per il web, l’odio degli italiani. Al di là dei pareri pubblicati su forum, blog, e quant’altro di discutibile possa influenzarci, alcuni ricercatori ed esperti italiani si sono posti delle domande, forse quelle giuste, sulla nascita del fenomeno. In particolare, una disamina molto fondata è stata stilata da uno studente dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Mattia Damiani, riguardo gli effetti del conflitto Israelo-Palestinese sull’opinione pubblica. Il risultato ha mostrato una polarizzazione tra antisemitismo ed islamofobia, essendo Israele principalmente popolata da ebrei e la Palestina da musulmani. Secondo l’autore non si tratta solo di sostenere una fazione piuttosto che l’altra, ma entrano in gioco anche fattori politici e ciò è stato riscontrato nella comparazione di due quotidiani italiani molto influenti sulla popolazione. Entrambi non si sono soltanto schierati con ideologie diverse, ma sono anche i portavoce di due versanti opposti della politica italiana: Damiani individua Il Giornale come esponente della destra filo-israeliana ed antislamista ed Il Manifesto nelle vesti filo-palestinesi ed antisemite della sinistra.
Su tale responsabilità politica non siamo in condizione di pronunciarci, né intendiamo farlo, ma in situazioni come questa ed altre, giornalisti con un ampio pubblico risultano i fautori principali della percezione che le persone hanno delle tematiche attuali, soprattutto per la scelta delle parole usate, che possono dare un senso più o meno velato dell’opinione che l’autore espone. Senza dubbio sia Damiani che gli esperti contemporanei, come il sociologo Stefano Allievi, concordano sull’11 settembre 2001 come spartiacque fondamentale tra un ancora vago scetticismo e l’islamofobia ben manifesta, in Italia come nel resto del mondo: è da quel giorno che gli islamici vengono associati quasi di continuo al terrorismo. Quest’elemento è stato evidenziato anche dal sociologo Marco Bruno in L’Islam Immaginato, secondo cui i principali veicoli di questo picco islamofobico sono stati proprio i media, che peraltro all’epoca non avevano la prontezza di oggi nel diffondere informazioni, ora che i social network massimizzano il panico di massa a partire da un solo post o tweet. In realtà, una definizione del fenomeno era stata già data anni addietro, nel 1997, da un’organizzazione inglese non governativa, The Runnymede Trust, che ne stilò una definizione in otto punti.
Un antislamico, dunque, reputa tale religione e chi ne fa parte: inamovibile dalle proprie posizioni, inconciliabile con altre culture, inferiore all’occidente, violento, che ha scopi politici, ignorato dall’occidente, ne viene giustificata l’esclusione sociale ed anche l’odio nei suoi confronti. L’opinione d’inferiorità lascia continuamente traccia nel privato e nel pubblico, come afferma la sociologa Maria Immacolata Macioti: “integrazione non è equivalente di assimilazione“. Questo termine, di cui la politica italiana ha fatto un abuso spropositato negli ultimi anni, ha assunto nelle aspettative del cittadino il significato di omologazione dello straniero, che ci aspettiamo giunga in Italia per essere salvato da un precedente stato “selvaggio” e civilizzato, che si presume impari la nostra lingua, i nostri costumi, il nostro stile di vita per abbandonare le proprie origini. L’aspettativa di un tale atteggiamento di sudditanza potrebbe essere considerata una riminiscenza delle antiche quando inestinte mire colonialiste europee, i cui cittadini si sentivano uniti nel patriottismo per la nazione conquistatrice e, nel caso degli italiani, anche nell’orgoglio scaturito probabilmente dall’ospitare lo Stato Vaticano nel territorio adiacente. Tra l’altro, da quest’ultimo elemento probabilmente è dipesa la lentezza con cui nuove religioni, ateismo ed agnosticismo si sono manifestate con piena consapevolezza ed accettazione in Italia, mentre l’abitudine prevalente era e forse è ancora quella di ostentare una religiosità ormai non più genuina.
Per quanto riguarda l’inamovibilità e l’inconciliabilità dell’islam con altre culture, in Italia hanno rafforzato questa convinzione alcuni eventi cruciali e messaggi diffusi da fonti di una certa influenza sulla massa. Infatti, entro un anno dall’attentato alle Torri Gemelle il cittadino medio si trovò nella posizione di doversi schierare pro o contro i musulmani. Il primo intervento sull’opinione pubblica fu il documento in cui il cardinale Giacomo Biffi di Bologna fornì indicazioni ai credenti riguardo l’immigrazione islamica, evento importante poiché segnò la percezione da parte dei cristiani di una minaccia al loro credo: l’islam e tutto ciò che lo riguardasse. Il passo successivo fu la protesta di Lega Nord contro la costruzione di una moschea a Lodi, a cui fu accompagnata un’aspra critica su uno dei quotidiani di maggiore influenza, Il Corriere della Sera, nei confronti del multiculturalismo e dell’integrazione dell’islam nella società italiana. Così torniamo a ricollegarci al ruolo dei media all’epoca, dei quotidiani e delle voci influenti nel giornalismo italiano, ma cos’è scattato nel profondo del singolo a partire da quest’intreccio di influenze sociali?
Anzitutto, è facile rendersi conto che il bisogno di appartenenza ad un gruppo fa parte della natura umana: motiva molti a schierarsi con fazioni fondamentaliste (che, patriottiche o meno, restano sempre tali) e tutti i fenomeni di massa, pur non essendone una giustificazione. L’islamofobia sembra seguire quasi lo stesso meccanismo delle mode passeggere, ovvero il contagio sociale, ma ha delle basi storiche e culturali così importanti da non poter essere sminuito in tal modo e, soprattutto, poggia sull’emozione primordiale dell’essere umano, che è la paura. Chi rifiuta l’antislamismo può quindi essere tacciato di noncuranza nei confronti del proprio territorio, della propria famiglia, di simpatizzare per il “nemico”. Un sillogismo implicito del genere può creare la frattura sociale già in atto in Europa, che ha spinto e sta spingendo ancora sempre più cittadini a schierarsi da uno o dall’altro fronte, dietro le trincee di una guerra su ogni piano. Lo dimostra il fatto che gli stessi terroristi dell’Isis diffondono sui social i loro video di esecuzioni e di minaccia per incutere terrore e soprattutto un clima di forte diffidenza. Da dibattiti sempre più feroci e dal proliferare dell’islamofobia essi ne guadagnano proseliti sia tra i musulmani che tra gli italiani, proprio in virtù di questa sorta di psicosi di massa, dove la fa da padrone una cessione di responsabilità delle proprie azioni e/o dichiarazioni, ad un gruppo di cui sappiamo avere il pieno consenso sociale, che esso sia fisicamente presente o che sia sparso in tutto il mondo. Tutto ciò che si può fare in questo caso è documentarsi, prendere le distanze dalla questione e fare una scelta etica a partire dalla propria visione del mondo. E se non se ne ha ancora una, prendere le distanze anche dalle imposizioni culturali finora seguite e creare uno spazio di discussione con se stessi inviolabile da alcuno e soprattutto in armonia con i diritti personali ed altrui ad ogni potenzialità della vita.